Da Gianni Principe un commento al decreto lavoro e agli emendamenti presentati in Senato, che rischiano di essere spazzati via se il governo vorrà mettere, come sembra, la fiducia (su un testo diverso rispetto a quello ‘imposto’ con la fiducia alla Camera):
Non sono i provvedimenti di legge che creano lavoro. Gli interventi legislativi cui va data la priorità sono, piuttosto, quelli che mirano alla semplificazione delle norme.
Sembravano queste alcune tra le principali linee ispiratrici del programma del Pd nella gestione Renzi, stando alle anticipazioni di inizio gennaio sul “Jobs Act”.
A sua volta il ministro Poletti, chiamato a delineare un quadro di prospettiva per quella che sarebbe stata la sua azione di governo (intervista a Repubblica del 16 aprile scorso), ha affermato che la soluzione per ridurre il peso dei contratti a termine non va cercata nei vincoli giuridici ma in un sistema di convenienze che porti il differenziale tra quei contratti e quelli a tempo determinato al 10% (almeno).
Un’affermazione che si colloca peraltro in continuità con tutta l’elaborazione degli ultimi anni del Pd (vedi Conferenza di Genova sul lavoro del 18 giugno 2011).
Il decreto sul lavoro va però in un verso diametralmente opposto. Entra minuziosamente nei dettagli, per i contratti a termine e per l’apprendistato. L’effetto è stato quello di incanalare il dibattito parlamentare esclusivamente su aspetti come la durata, il numero delle proroghe, i contingenti, per i contratti a termine; la forma scritta o orale dei piani formativi, le quote di assunzioni vincolanti per l’apprendistato. Una contesa tra chi, da una parte, presume che abolire tutele giuridiche per i “prestatori di lavoro” accresca la competitività delle imprese sul mercato e chi, dall’altra, attribuisce poteri salvifici, di tutela delle condizioni di reddito e di lavoro, alle prescrizioni normative e su quelle scende in trincea.
Eppure si poteva sperare che fossero mature le condizioni per imboccare un’altra strada. Sarebbe ancora possibile, ma dovrebbero verificarsi due condizioni. Il decreto dovrebbe essere ritirato e lo stesso disegno di legge sul “Jobs Act” dovrebbe essere reimpostato e cedere il passo a un testo di merito. Come del resto si dovrebbe (tornare a) fare, stando al passo n. 22 dell’elenco dei (44) passi necessari per riformare la macchina burocratica, contenuti nella lettera del premier e della ministra Marianna Madia ai dipendenti pubblici: “leggi auto-applicative; decreti attuativi, da emanare entro tempi certi, solo se strettamente necessari”.
I quattro emendamenti al decreto Poletti presentati in Senato dai senatori Ricchiuti, Albano, Casson, Mineo, Tocci, intendono andare in questa direzione.
Se non si dovesse arrivare alla decisione di ritirare ill decreto, possono infatti rappresentare almeno un passo verso la semplificazione normativa e, insieme, verso la costruzione di un sistema di convenienze a favore del lavoro stabile, con l’effetto non secondario di spingere ad investire sulla cosiddetta “via alta” alla competitività.
L’idea alla base degli emendamenti è quella di consentire maggiore flessibilità nelle fasi iniziali di un rapporto di lavoro, riprendendo l’ipotesi di un contratto di inserimento “a tutele crescenti”. L’intervento ipotizzato, però, anziché prevedere l’istituzione di un ulteriore, nuova tipologia, agisce sull’esistente contratto “tipico” a tempo indeterminato modificando gli attuali termini del “patto di prova”, portandoli da sei mesi a tre anni. Viene dunque a cadere la ragione stessa della previsione di un contratto a termine di quella durata senza causali.
Nel momento in cui concede questa facoltà, la legge prevede alcuni necessari contrappesi: un primo, rappresentato dalla contrattazione tra le parti, cui spetterebbe, ai vari livelli (dal contratto nazionale all’aziendale secondo l’impianto attualmente in vigore) la scelta di avvalersi o meno di questa facoltà; un secondo rappresentato dal maggiore onere che l’azienda sarebbe chiamata a sostenere quando la durata del periodo di prova dovesse superare i sei mesi (cioè il termine previsto dalla normativa ora vigente), in quanto sarebbe estesa al lavoratore in prova, per il periodo tra i sei e i trentasei mesi, la previsione attualmente applicata per i lavoratori somministrati, di un prelievo pari al 4% della retribuzione lorda, destinato a programmi di formazione (di base, trasversale, on the job, esterna) e a tutele di natura assistenziale (congedi, garanzie per mutui, contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione). Parliamo di un istituto che, nella esperienza quasi ventennale di applicazione, è stato oggetto di successive regolazioni per via contrattuale e di aggiustamenti normativi, quanto alle possibili destinazioni, con reciproca soddisfazione delle parti in causa.L’ultimo contrappeso sarebbe infine rappresentato, va da sé, dal ritorno del contratto a termine nell’alveo appropriato, quello per cui è stato storicamente previsto, della sostituzione e della stagionalità.
Non viene così stabilito, si noti, un differenziale del 10%, come auspicato dal ministro del Lavoro, a favore del contratto a tempo indeterminato, quello che le direttive europee indicano come “normale” rapporto di lavoro, ma si compie pur sempre un passo significativo in quella direzione.
In più, aspetto non secondario, non risulterebbe cannibalizzato l’apprendistato, che accrescerebbe anzi il suo “appeal” per i neo-assunti più giovani. A condizione che non si attenui il contenuto formativo ma lo si renda casomai più utile e più interessante per l’azienda e per il lavoratore, ampliando la scelta e rendendo più penetranti e incisivi i controlli di qualità. E che si dia un impulso significativo alle due tipologie di apprendistato fin qui neglette, quello in età di obbligo (o diritto-dovere che dir si voglia) formativo e quello di alta specializzazione. Temi questi che, insieme ad altri nel medesimo indirizzo, dovrebbero essere oggetto della legislazione di merito, “auto-applicativa” (e non delegata a decreti attuativi di là da venire), con cui dar corpo al tanto atteso “Jobs Act”.
Resta da dire che, in subordine, qualora prevalesse l’orientamento di non abolire l’istituto del contratto a termine al di fuori dei casi di sostituzione e stagionalità, due emendamenti alternativi prevederebbero di sostituire, in mancanza di causali, il complesso di norme in materia di proroghe, fermo restando il limite dei 36 mesi, con la previsione del prelievo del 4%, uniformando gli oneri connessi al contratto a termine a quelli applicati per la somministrazione.


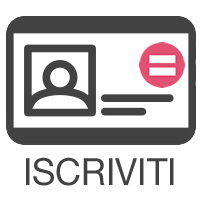









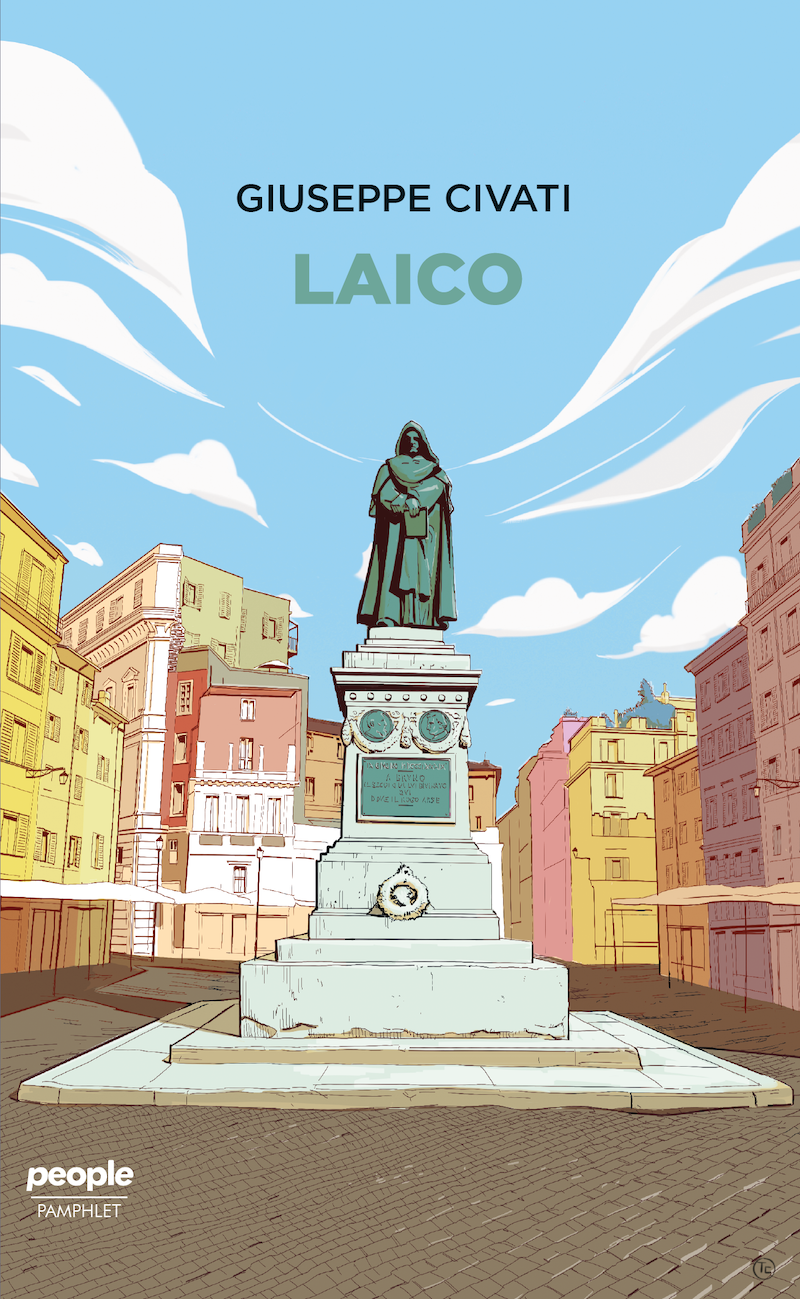










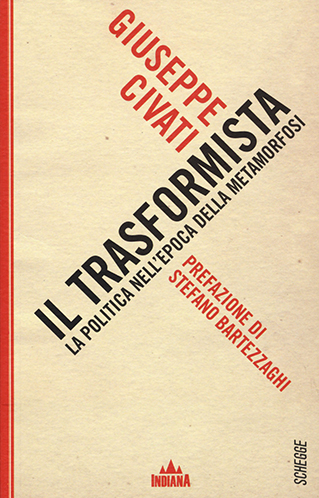


Comments (4)