Scrivo dall’Estonia, un paese che ha conosciuto, fin dalla sua indipendenza (esattamente cent’anni fa), occupazioni, spartizioni e conseguenti deportazioni, violenze – tra nazisti e sovietici, soprattutto, che prima si erano messi d’accordo e poi si combatterono proprio sulla linea di quello che divenne un «corridoio», attraversato dalle cose più disumane che si potessero immaginare.
L’Estonia ci ricorda che l’Europa ha conosciuto tutto questo solo due generazioni fa.
A proposito di invasioni, quelle vere.
Invasioni che sono andate e venute, in una direzione e in quella opposta, come le nuvole che corrono lontano e si succedono, come il tempo che qui cambia in continuazione (quando ho iniziato a scrivere, pochi minuti fa, nevischio, ora sole e cielo azzurro, tra poco grigio?). Una fortezza che sembra Got, sullo sfondo. Che però non è servita a molto, la fortezza.
L’Estonia ci ricorda, in un denso lavoro culturale sulla propria «identità» che attraversa ogni conversazione, che il finisterre europeo e i suoi confini continuano a essere una questione politica centrale. Stupisce che l’Europa abbia rimosso il piccolo particolare che tutto questo ha riguardato gli europei, appunto, e non si curi ora di ciò che accade ai suoi «margini», con una propria diretta responsabilità, politica e economica. Eppure lo sappiamo, perché lo abbiamo vissuto, e non nel paleolitico, solo pochi anni fa.
Alexander Langer scrisse nel 1995 che «l’Europa muore o rinasce a Sarajevo», ora potremmo dire che l’Europa si fa nel Mediterraneo, in Libia, sulle coste della Turchia. L’Europa si qualifica a Ventimiglia, a Bardonecchia. L’Europa esiste se si confronta con ciò che le sta accadendo. E se reagisce, con una politica che da Tallinn la attraversa, giù giù, fino a Lampedusa. E che affronti la questione sociale (le maledette disuguaglianze) insieme alla questione migratoria, due elementi che si richiamano e che se non affrontati entrano in un conflitto inevitabile e in una spirale regressiva e potenzialmente devastante.
Leggere qui 1947 di Elisabeth Åsbrink (Iperborea) ha un significato particolare. Il libro racconta un anno intero, quel 1947, in cui tutto era possibile perché tutto, anche l’indicibile, era appena accaduto, non molto lontano da qui, tra l’altro.
Nel 1947 fu coniato il termine genocidio, che prima nemmeno esisteva, la guerra era finita ma proseguivano la fame e la disperazione che aveva causato, la violenza si trasmetteva ancora, in Palestina e in India, ad esempio. Il mondo ripartiva e però, troppo spesso, tornava sui suoi passi: si affacciava su una nuova epoca con un carico di desolazione e di speranza.
La storia personale riassume la storia globale, per Åsbrink, in pagine struggenti, a metà del suo racconto di quell’anno. E a sua volta sono riassunte nei pensieri che la scrittrice svedese affida a uno dei suoi protagonisti, uno dei protagonisti del 1947, Rapahel Lemkin:
È facile commettere un genocidio, constata Raphael Lemkin, perché nessuno vuole credere che possa accadere fin quando non è troppo tardi. Là fuori il mondo ripete: «Mai più». Ma Lemkin conosce la storia del genocidio, sa che la logica invece dice: «La prossima volta». È successo, quindi può succedere ancora.
E succede, ancora. E succederà. Non dimentichiamolo: «Il dolore si tramanda, in un flusso costante che passa dall’ordine al disordine, ed è impossibile che torni indietro».
Sta a noi, ogni volta, decidere che cosa fare. Che parole usare. Che azioni compiere.


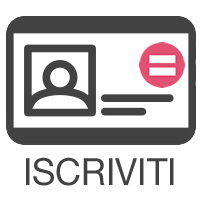









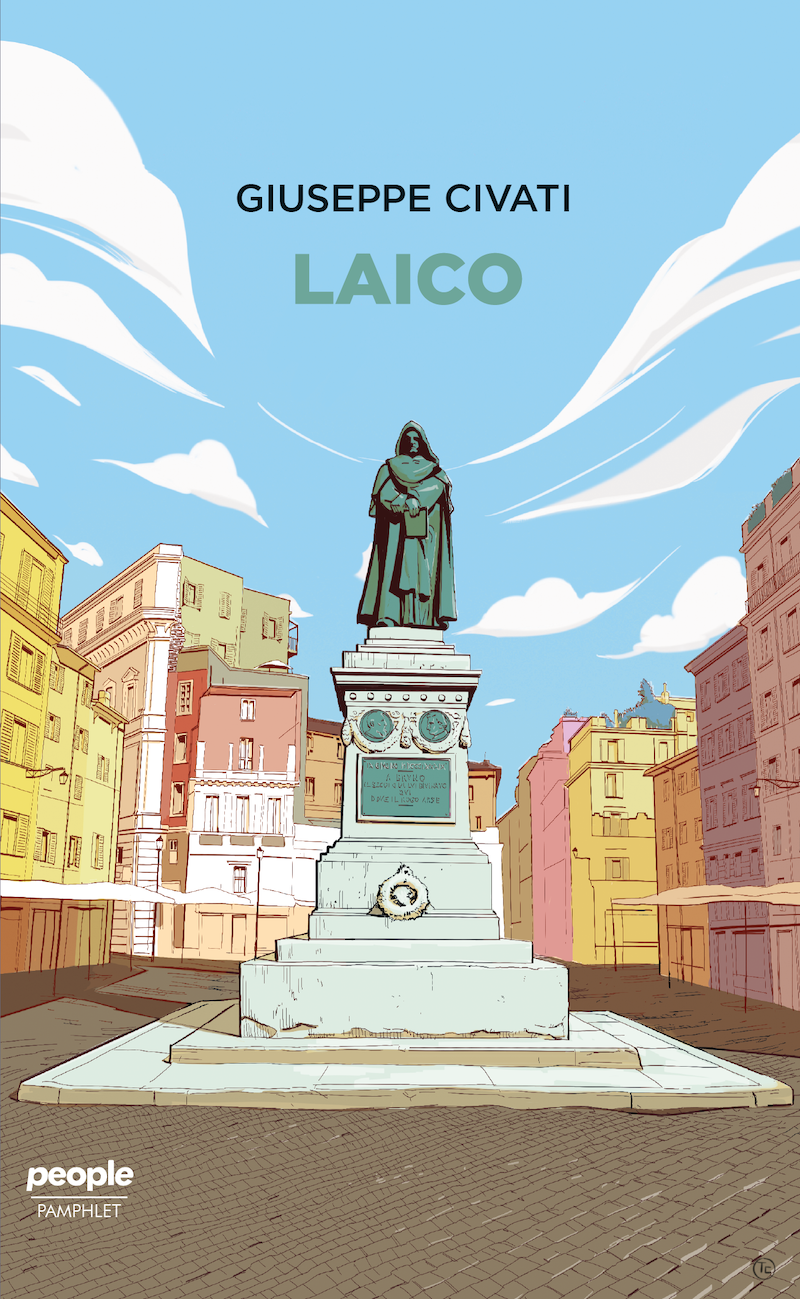










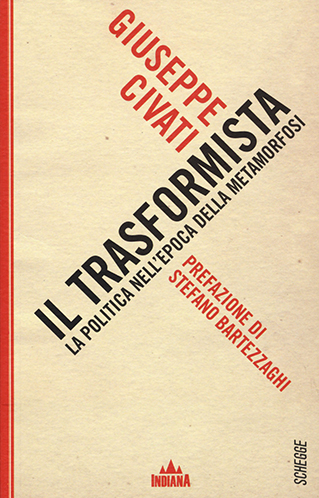


Comments (0)