
Mentre si sciolgono i ghiacciai, si scioglie tutto. Il diritto internazionale, negato, la nostra cultura giuridica (Beccaria, portami via). A las cinco de la tarde di ogni santogiorno si sciolgono anche le Camere. Si sciolgono definitivamente le righe dell’Antiorario Tour e si torna a casa. Ritorno e nostalgia, si sa, sono una cosa.
Vi avevo detto che Zeus non sarebbe stato benevolo, tutt’altro. Lo abbiamo sfidato, del resto: abbiamo sacrificato una batteria ad Atena, attualmente la meno popolare degli dei. Fatto sta che oggi, dopo giorni di canicola, pioviggina e la temperatura si è abbassata di una decina di gradi. Grazie, Zeus.
Non ho niente da ricaricare. Nemmeno me stesso, perché i chilometri mi fanno bene, in Brianza si soffre l’inerzia. Prendo un treno, stracarico di libri, perché come vi avevo detto i libri si vogliono bene tra loro, e a ogni presentazione te ne regalano uno, due, tre. Fino a comporre una intera valigia supplementare.
«Gli altri parlano del tempo, noi no», diceva un vecchio adagio. E invece il tempo è centrale. Anche perché di tempo non ne abbiamo più. Lo dice Franzen in pagine mirabili, lo ripetono gli scienziati da quarant’anni, Greta sta perdendo la pazienza, le previsioni peggiorano più velocemente delle stesse condizioni meteorologiche.
L’Antiorario è un tentativo di fermare il tempo. Non per rendere fisso il presente, a quello già pensa il ridondante circuito della politica e dell’informazione, un circolo tipo uroboro. È il tentativo di far tornare indietro le lancette di questo orologio collettivo che scandisce ritardi, disuguaglianze, colpe, prima che scatti l’ora X, in cui la X la metteremo sul pianeta stesso.
Tutti parlano di cosa succederà stasera, qualcuno impavido si spinge addirittura fino alla settimana successiva. Si naviga a vista, in una tempesta di volgarità e eccessi. Tutti ossessionati dalla finestra per il voto. Una finestra che sbatte tra polemiche inutili e fittizie – tra le fake news poteva mancare la fake crisi? – per poi richiudersi un attimo prima che chiudano i giornali.
Lo statista guarda alle future generazioni, il politico alle future elezioni, il cretino guarda alla futura agenzia di stampa.
Se ne discuteva nelle ultime ore sui social. Tempo fa mi sono dato “la regola delle 48 ore”: vale per la cronaca nera, vale per la cronaca politica, vale soprattutto quando le due s’incontrano. Non è necessario commentare sempre tutto, è grave farlo senza sapere nulla di ciò che si commenta. Diventa schifoso se interessato.
Scopro ora che ne scriveva un secolo fa (o quasi) Simenon, di cui si è uscito mentre viaggiavo Il Mediterraneo in barca (Adelphi). Sì, uno dei libri degli altri, un reportage che ti fa riflettere a ogni pagina.
Dai giornali apprendo che a Parigi ci si preoccupa dei congressi di partito, di unità o mancanza di unità, oltre che di un delitto commesso dal figlio di non so più quale procuratore.
Qui, invece, ci preoccupiamo di sapere quale vento soffierà domani, e i miei uomini, sotto un sole che già picchia duro, fanno rotolare dei grossi barili d’acqua dolce che l’argano consegna a bordo cigolando.
Paure piccole e cattive, nessuna visione, solo scaltrezza nel portare via il consenso, con destrezza (appunto). Senza spessore. Con una patina di strumentalità che copre tutto. Il fine non giustifica i mezzi. Ci sono solo i mezzi. Mezzucci. Che alimentano se stessi.
Tutto è momentaneo. E allora riempire un furgoncino di libri, propri e altrui, ha il significato di recuperare lentezza, decelerare, abbassare i toni, scegliere vie laterali, secondarie, mete non dettate dal numero o dalla popolarità. In profondità.
E il viaggio proseguirà con le Previsioni del Tempo, con la rassegna dei libri degli altri, con altri libri ancora e un momento a fine estate in cui fare il punto. E partire ancora.
Catone, nel più classico dei «tu quoque», mi canzona: «Civati, scrive, conosce i venti e le correnti, e i segreti della mobilità elettrica, dice». Niente di tutto ciò, solo la ricerca di soluzioni inesplorate, che rendano obsoleto il modello che abbiamo ricevuto in sorte. Non è una necessità, ci vuole la libertà di cambiare. Le alternative ci sono sempre e ora sono l’unica cosa necessaria, le alternative.
Dentro il problema della fine del mondo, legato alla fine del mese – clima e disuguaglianza sono fratello e sorella e si alimentano a vicenda -, c’è anche il problema dell’Italia. Perché se il mondo dovesse finire, finirebbe anche l’Italia, lo dico per i più acuti tra i sovranisti. Ma se il mondo non dovesse finire, noi perderemmo posizioni, perché stiamo perdendo tempo in assoluto ma anche nel confronto con altri, più cauti, previdenti e innovativi di noi.
Lo scriveva (bene, come sempre) Mattia Torre che ci ha lasciato dieci giorni fa, rispetto alla colpa che è sempre degli altri e di un Paese in cui tutti vorremmo essere altro. Come mera proiezione di sé, rovesciata. Ed è incredibile che, nella ossessiva rivendicazione di un’identità, questo Paese non trovi più se stesso, ciò che sa fare, ciò che in fondo è.
L’Italia è il Paese in cui tutti vorrebbero stare da un’altra parte, in un altro paese, chi in un altro quartiere, chi dentro un altro matrimonio, chi a fare un altro mestiere. Solo pochi, pochissimi sono contenti di stare nel posto in cui si trovano.
Michele Zamagna, chirurgo urologo: opera.
Sono le persone che sono felici di stare nel posto in cui si trovano, che danno un senso alla propria vita, perché fanno bene il loro lavoro. Fanno ciò che desiderano. Sono cittadini di un’altra era, ma di un’era che deve ancora venire, non hanno bisogno di glorificare se stessi, sono felici perché sono innamorati di quello che fanno, hanno il senso degli altri, il senso della comunità, danno un contributo al Paese non solo con il loro lavoro, che pure è importante, ma con la serietà che mettono nelle cose. La loro vita ha un senso.
Torno da Nina, mia figlia, perché lei è la ragione di tutto quanto.
L’Antiorario, forse, è proprio questo: un viaggio di ritorno verso mia figlia, verso i nostri figli. E un tuffo nel passato per trovarvi indizi circa il nostro futuro. Come potrebbe essere, come dovrebbe essere.
E l’acronimo Tina – «There is no alternative» – diventa Nina – perché «Nina is needing alternatives». Più di una, di alternativa. A comporre un grande progetto, una grande sfida collettiva. Le soluzioni politiche e tecnologiche le conosciamo, dobbiamo solo fare ciò che è giusto, altrimenti saremo noi a diventare fossili.
Per contrastare gli alieni o per deviare l’asteroide, come in quei film americani in cui tutti si uniscono anche se si odiano in modo vatiniano, per salvare il pianeta e se stessi. Sapendo che questa volta l’asteroide, gli alieni proprio, siamo noi.


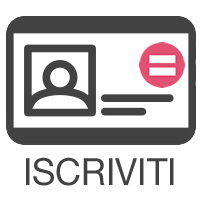









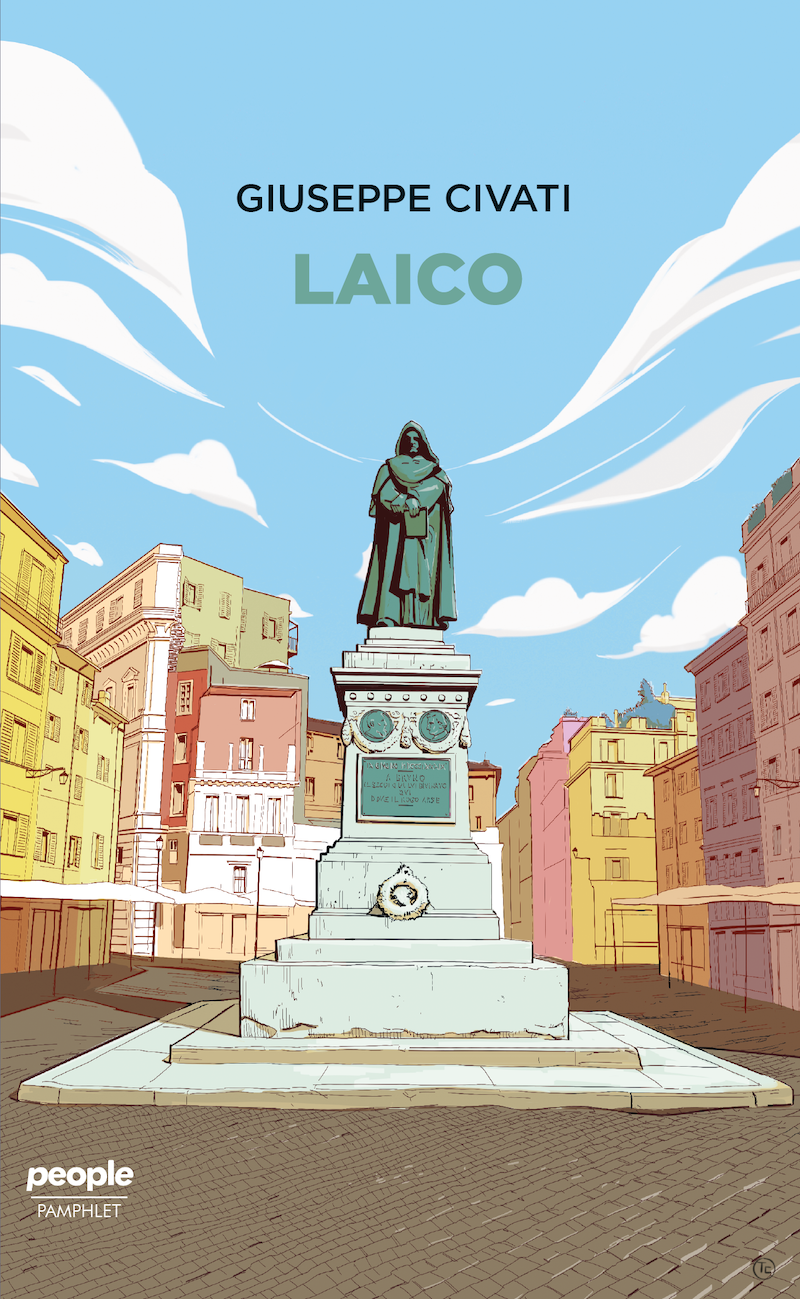










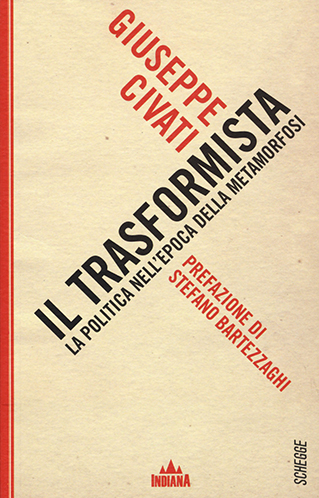


Comments (0)