
Prosegue il diario-reportage di Giulia Montorzi dall’ospedale di Prato.
La verità è che ci hanno preso in giro.
La “Fase 2” non è ancora iniziata, ma non si ha il coraggio di dirlo.
La ragione è un R0 che è calato, sì, ma non quanto ci si aspettasse. E, sicuramente, non quanto necessario.
L’R0 è il valore di riproduzione di base che rappresenta il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto in una popolazione completamente suscettibile, cioè mai venuta a contatto con il nuovo patogeno emergente.
Questo parametro misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva.
Ecco, l’attuale livello raggiunto – in media di 0,5 – 0,6 – non è tale da far pensare che al momento della riapertura questo valore non aumenti fino a superare un’altra volta la soglia (>1) che metterebbe nuova pressione al sistema ospedaliero, e che potrebbe innescare nuovi focolai di trasmissione.
Sono un’infettivologa, e non posso che condividere questo concetto.
I punti critici però, a ben vedere, sono due.
Il primo è scientifico: il calo di R0, per nulla soddisfacente dopo ben 40 giorni di lockdown, imporrebbe una riflessione sulle cause e la pronta attuazione di misure correttive.
La ragione – a mio avviso – è l’assenza di una politica di sanità pubblica territoriale, che consenta una sorveglianza epidemiologia sui territori, appunto.
I programmi di controllo delle malattie infettive si basano sulla ricerca attiva dei contatti, dei casi di infezione e del loro isolamento.
L’obiettivo più importante dell’epidemiologia delle malattie trasmissibili è quello di chiarire i processi di infezione al fine di sviluppare, mettere in atto e valutare appropriate misure di contrasto alla loro diffusione.
La sorveglianza è parte essenziale nel controllo della malattia.
Esistono vari modi per impostare un sistema di sorveglianza.
Il più importante di questi è un sistema routinario che registri l’eventuale caso di infezione all’interno del sistema sanitario: di norma si realizza con la compilazione di una notifica di malattia infettiva da parte del medico che fa la diagnosi, che viene prontamente trasmessa ai servizi di igiene territoriale.
Una volta inviata questa notifica ai servizi di igiene, prende il via un sistema di controllo della diffusione dell’infezione che può comportare, ad esempio, la ricerca di sorgenti di infezione ambientale e la loro sterilizzazione (come accade per ii casi di legionella), la somministrazione di farmaci in profilassi i (ad esempio nel caso dei contatti da meningite meningococcica), lo screening dei contatti (come nel caso di TBC), l’identificazione di asintomatici e sintomatici lievi con successiva quarantena (come dovrebbe essere per il COVID).
Non riesco ancora a spiegarmi perché queste procedure, che si attuano normalmente, non sono state poste in essere in occasione della più grande epidemia degli ultimi 100 anni.
Nel caso del COVID19 rimane un’immensa lacuna della gestione delle informazioni, per non parlare della totale assenza di controlli in intere Regioni del Paese al fine di certificare la reale negativizzazione degli infetti prima di dichiarare la fine della quarantena.
Questa fase doveva essere programmata e attuata già da tempo, testando attraverso i tamponi i contatti dei casi positivi e, in modo ancora più auspicabile e ardito, effettuando screening sierologici con test su prelievo di sangue capillare (facilmente attuabile su larga scala), seguito da tampone nel caso di risultato positivo per escludere la contagiosità.
A seguire, dovrebbero intervenire provvedimenti di isolamento, con sostegno e controlli da parte dei servizi territoriali, e non certo – come è capitato – limitarsi all’abbandono domiciliare dei positivi convalescenti a data da destinarsi, o con tempi di isolamento generalizzati e determinati a priori, che già si sono dimostrati scarsamente attendibili (la negativizzazione può richiedere ben più dei 14 giorni stimati e attualmente usati come tempistica di riferimento).
Un approccio programmatico avrebbe consentito uscite in tempi scaglionati sulla base di un criterio scientifico, che davvero avrebbe reso la
“Fase 2” una ripartenza protetta.
Inoltre, se questo fosse stato fatto durante il lockdown, l’identificazione e l’isolamento dei contatti di infetti, asintomatici o sintomatici lievi, avrebbe probabilmente condotto oggi ad R0 differenti da quelli che abbiamo.
E arrivo quindi all’altro punto critico: quello politico.
Questi provvedimenti serviva farli ieri, ma andrebbe bene anche se fossero fatti oggi.
In ogni Regione, gli addetti ai lavori hanno un’idea spesso vaga di quello che sta succedendo sul territorio di loro competenza: per questo sarebbe necessario un piano nazionale.
Perché non sono state attuate politiche di questo tipo? Per mancanza di fondi?
Perché non si è seguito l’esempio della regione Veneto che, attuando questa politica, ha limitato i focolai di infezione in modo visibilmente più efficiente rispetto ad altre aree?
Perché si preferisce enunciare l’inizio di una “Fase 2” lacunosa – e resa ancora più complicata dalla poca chiarezza sul significato di “congiunto” -, che si arricchisce di provvedimenti di difficile comprensione, scarso valore scientifico che prestano il fianco ad essere elusi e aggirati da cittadini stanchi e confusi?
Provvedimenti, tra l’altro, mi permetto di dire basati su criteri valoriali e sociali anacronistici rispetto alla società contemporanea, e quindi discutibili e sottoposti necessariamente a continue precisazioni a posteriori che li rendono degni di Azzeccagarbugli.
E tutto questo rischia, davvero, di far ripartire solo il virus. Non di certo il Paese.


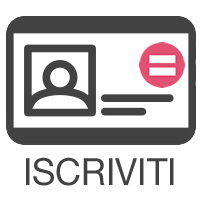









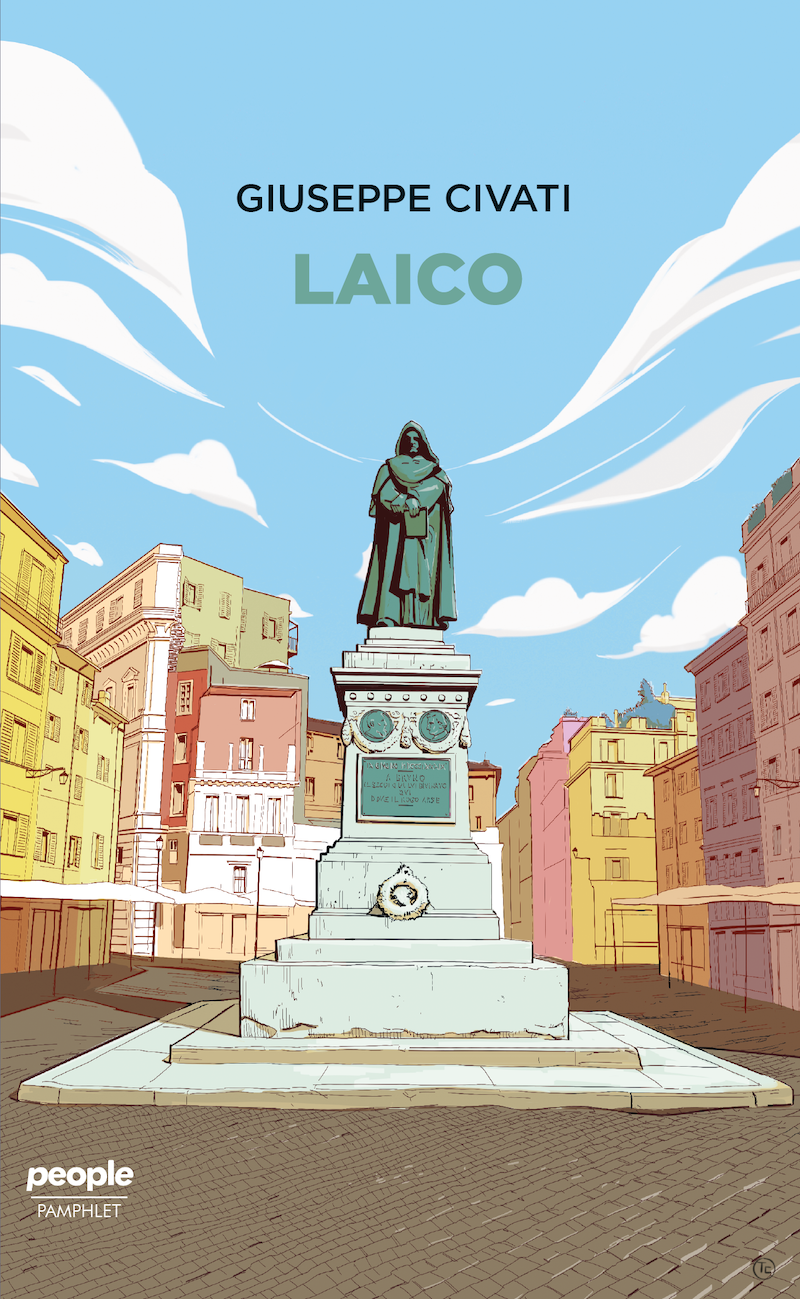










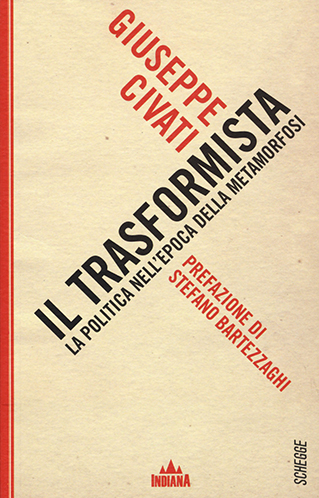


Comments (0)