Il grande capo è una delle commedie più divertenti degli ultimi anni. Straordinario il soggetto, spericolata la sceneggiatura, perfetta l’interpretazione del protagonista. La storia, che vi accenno soltanto per consentirvi una visione illibata, è geniale: in una Danimarca che sembra la Manhattan di Woody Allen, un attore viene incaricato di assumere la parte del grande capo in un’azienda che ne è priva, perché il secondo (che in realtà è il primo) ha scelto di inventarsi questa figura, per gli scopi più disparati. Lars von Trier disegna così un percorso formidabile attraverso i luoghi comuni delle aziende e rappresenta una straordinaria parodia del mondo delle multinazionali, dei meccanismi di funzionamento delle aziende e, se si vuole, dell’intera società turbocapitalistica. L’attore avrà una parte molto superiore al suo incarico iniziale, in un perfetto rovesciamento di realtà e finzione che caratterizza perfettamente i costumi del nostro tempo (devastato e vile, come appare ad un certo punto l’azienda in questione). Ancora più forte è la lettura per così dire filosofica: la necessità per tutti, anche per il suo inventore, di avere un grande capo, di creare una figura dominante che organizzi – a prescindere dalla propria esistenza, un dato tutto sommato secondario – i lavori e i comportamenti di tutti. Viene in mente, tra una risata e l’altra, una certa critica à la Feuerbach, quando attacca quel fenomeni che si è soliti chiamare "ipostatizzazione". Anche se il capo non c’è, bisogna inventarlo, per il bene di tutti. Come è perfettamente hegeliana la necessità, quand’anche negata, di ottenere il ‘riconoscimento’, financo nella versione da soap opera del sentirsi amati, quando non proprio al centro dell’attenzione, pardon, volevo dire scena. Precipitatevi al cinema.


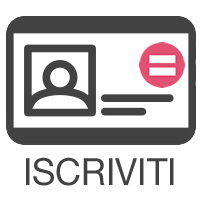








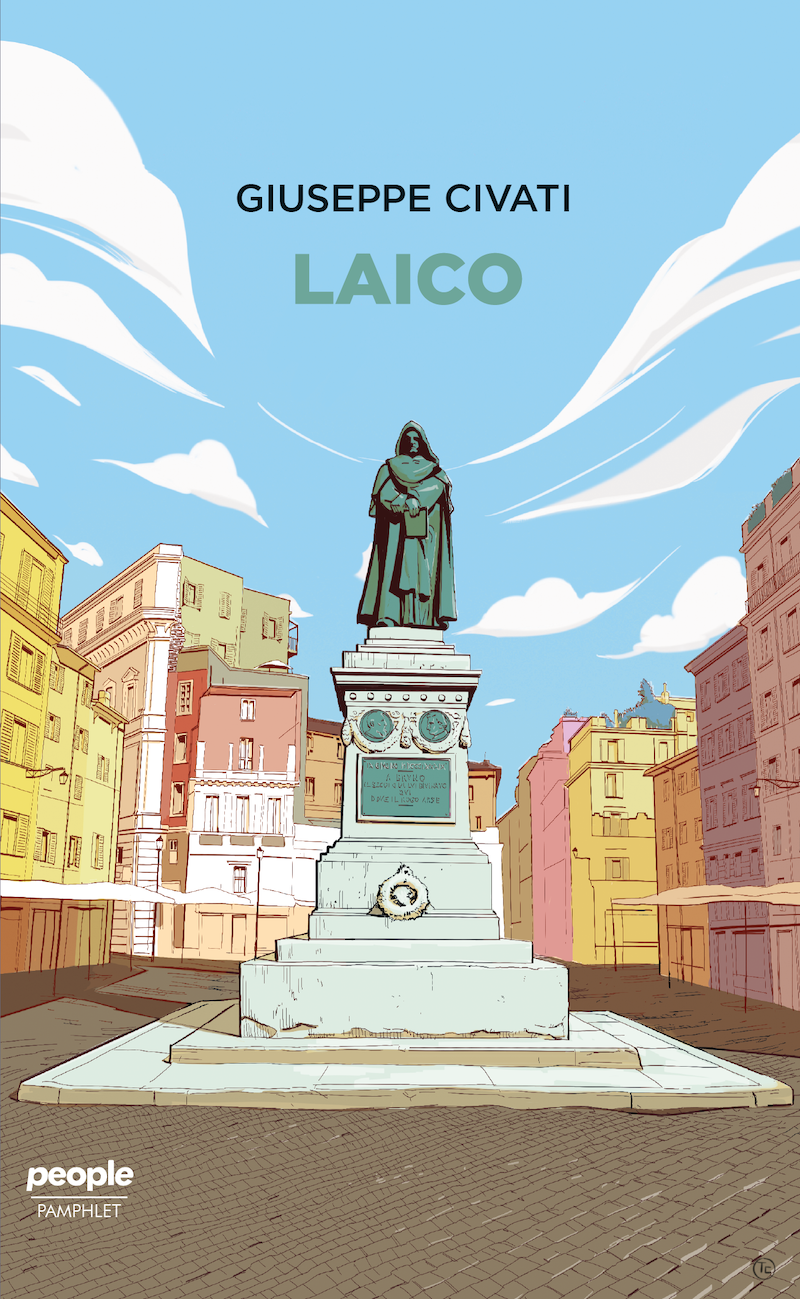










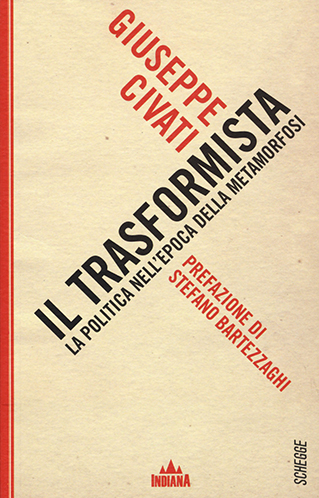


Comments (1)