
Dopo qualche ora, pochi giorni, ti pare di essere sul lago di Gusana da una stagione intera. E che le strade e le case ti siano familiari come se quel dedalo avesse un filo d’Arianna incorporato. Tutto è pietra, pedra, perché nessuno si perda.
Così come quelle colline tutt’intorno che non sembra ‘esattamente’ una cartolina della Sardegna, il posto in cui ti trovi.
Poi quando finalmente te ne vai, ti coglie il mal di Gavoi.
Torni nello sproporzionato, nel fuori di sesto, nella notte della dismisura, in cui tutto sembra assurdo, anzi, grottesco.
A Gavoi regna l’equilibrio. Tutto è proporzionato. Piccolo si dirà, ma è evento regionale – di una regione intera – per la partecipazione. E nazionale – e molto di più – per la qualità.
E certo la spiegazione si trova nella formula, nel programma, nella sapienza maturata in sedici edizioni. E certo nel modo di scandire il tempo, con quell’orologio della chiesa che indica sempre la stessa ora. Ma è soprattutto nelle persone che incontri. Ospiti e no, tutti sembrano d’accordo e congiurano per farti stare in equilibrio.
Anche il perfido Marcello (Fois), iniziando, dice proprio così: senza Gavoi non può esserci il festival, senza il festival non sarebbe davvero Gavoi.
Potrebbe essere la fraternité a cui ci richiama Giacomo (Papi), la sorella minore-cenerentola di libertà e uguaglianza che però le tiene insieme e le rende possibili.
Potrebbe essere l’umanità di Francesca (Mannocchi), la sua e di ciò che dice e di ciò che auspica. E di ciò che, auspicando, ci rimprovera.
O le foto con il tondo nero di Daniela (Zedda), come un carnevale che dura tutto l’anno, alla rovescia. Che vogliono dire tante cose, quelle facce bollate di nero. Sono le nostre.
Non è una mistificazione, al massimo una mirtificazione, come ti spiega il fonico di Bassano del Grappa, all’insegna del toponimo, quando ormai è troppo tardi per dare la parola. La parola la si prende, a quell’ora, riempiendo il bicchiere.
In generale le persone non si fanno problemi. Non ne creano, ma non se ne fanno nemmeno loro, a proporsi come sono. E chiedono che tu sia come sei. Hanno un particolare detector, a Gavoi, per i presuntuosi e gli stronzi. E sono implacabili. Come Fabio (Geda), che però ha una parola giusta, misurata, per tutti. Poi lo sai che non la pensa sempre e proprio così, ma Geda per me è l’uomo di Gavoi. Non essendolo di origine, appunto: l’identità è cosa complessa, mutevole, sotto quel cielo.

Mille persone sotto una luce meridiana, un calore da ebollizione, in cui tutto è insieme realtà nuda e cruda e fata morgana – a me ascoltando Tochman, dal caldo torrenziale, è parso di conoscere il polacco, di non avere bisogno della traduzione.
E i bambini che laborano, il verbo che mi pare vada usato guardandoli nei laboratori o ascoltando qualcuno che legge, come il prode Alfonso (Cuccurullo), che a dispetto del cognome – sardo, a suo modo – legge cose di paura, da paura.
E uno Stefano (Catone) che tra tanti fuoriclasse intorno si capisce che si farà, che ha talento. Ha spirito.
E un balcone, la mattina, con centinaia di persone che ascoltano, che solo a Gavoi possono permettersi un balcone, con tutto il recente ribollire da Ventennio. Un balcone da cui parlare di romanzi. Non di proclami. Se non di stile e bellezza. Ogni tanto passa un ape piaggio, applauso.

E la notte, a perdere navette, a chiedere ancora un minuto, perché c’è una storia che l’indomani potrebbe non esserci più, e nessuno a raccontarla.
Gavoi non esiste. O almeno, secondo lo spirito del tempo, non dovrebbe.
L’anno prossimo vado a controllare, perché non mi fido. Forse mi sono inventato tutto. O forse l’hanno fatto altri per me. E non so come ringraziarli.


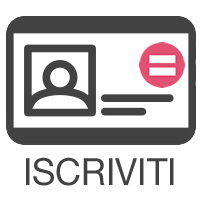








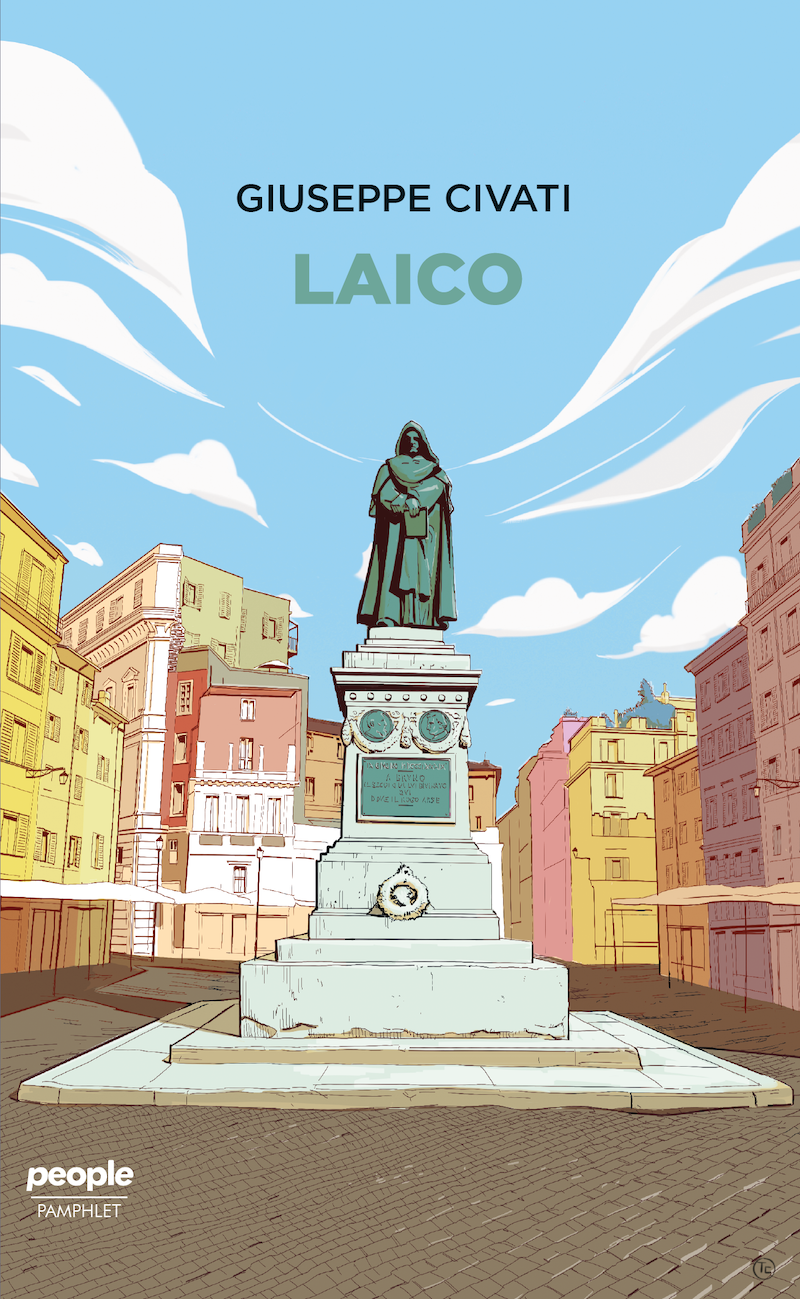










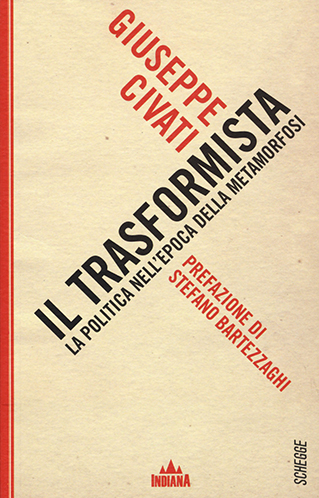


Comments (0)