l quarto post da Washington. Ora si va a Philadelphia. See you later.
Si inizia presto con un breakfast di una senatrice della California che incontra studenti, famiglie, lobby grandi e piccole, rappresentanti istituzionali di tutti i tipi, offrendo loro un succo e una ciambella. Perché così si mantiene un contatto con l'elettorato, soprattutto se lo Stato di provenienza è lontano. Già.
Si prosegue con una visita al Congresso, dove in aula non c'è nessuno, e sembra tanto di stare a Montecitorio, con il vantaggio, direbbero gli strateghi delle riforme, che il bicameralismo non è perfetto, e c'è il senato federale. Che qualcuno ricordi che l'Italia sarebbe uno Stato degli Stati Uniti, non gli Stati Uniti, per incominciare.
Poi, finalmente, la biblioteca, dove ci sono tutti i libri del mondo (pare anche quelli del vostro affezionatissimo, per dire quanto sono generosi). Il motto stampato dappertutto è fantastico: «I can't live without books», lo ha detto Thomas Jefferson. E a me è venuto in mente B e il fatto che si vanta di non leggere un libro da secoli (salvo Erasmo, of course, perché lui ha scritto la maledettissima prefazione all'Elogio della follia, peccato solo non l'abbia capito). E ho pensato che se uno andasse in televisione a dire che non riesce a vivere senza libri sarebbe considerato uno snob di cui diffidare, un elitario che non capisce il proprio tempo, un visionario che vive di suggestioni letterarie e che non è radicato nel territorio. Già.
Sulla volta della fantastica sala centrale, campeggia l'Italia, e anche la Roma classica e anche l'Islam. Già. Così succede anche con i medaglioni della House of Representatives, che riportano tutti i predecessori che gli americani sentirono il bisogno di scegliersi.
Nel pomeriggio, si passa a parlare di cose più attuali. Ad esempio del Tea Party. E ad esempio del fatto che il Tea Party abbia deciso di sostenere a spada tratta la legge sull'immigrazione dell'Arizona, quella che consente ai poliziotti di chiedere i documenti a quelli che sembrano clandestini, ovviamente dal colore della pelle, come primo 'indicatore' (cose che da noi non farebbero nemmeno più notizia: forse potrei fare il consulente per l'amministrazione Obama, con delega ai new leghist).
La contraddizione è che il Tea Party vuole che lo Stato si faccia gli affari suoi, salvo ovviamente se si tratta di presunti clandestini: in quel caso «mettere le mani nelle tasche dei cittadini» diventa necessario, ovviamente. L'altra contraddizione è che il Tea Party riprende il motto No taxation, without representation, come se il problema degli americani di allora fosse la taxation (era, invece, ovviamente, la representation e Londra non era ladrona, ma tiranna, se così si può dire).
Mentre parlavano gli esperti (che per una volta erano esperti davvero), a me è venuta in mente la cosiddetta variante di Adro al Tea Party. Perché, primo, in Italia, per gli stranieri regolari, in presenza di taxation, è proprio la representation a essere negata. E, secondo, perché – se ci pensate – con la vicenda delle rette di Adro si è introdotto un principio di grande interesse che diventerebbe rivoluzionario se fosse applicato alla questione fiscale (e non solo alle rette scolastiche che, si è scoperto poi, riguardavano per la maggior parte famiglie parecchio indigenti, che non potevano accedere ai servizi sociali). Ecco, immaginate se a «quelli che… no taxation» (quelli che le tasse non le pagano) fosse tolta anche la representation (non solo dal punto di vista elettorale, ma come 'copertura' dei servizi essenziali, proprio quelli che sono finanziati attraverso la fiscalità generale). Sarebbe una battaglia culturale di tutto rispetto. Il Tea Party: nel caso, però, il tè sarebbe verde.


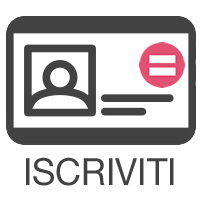








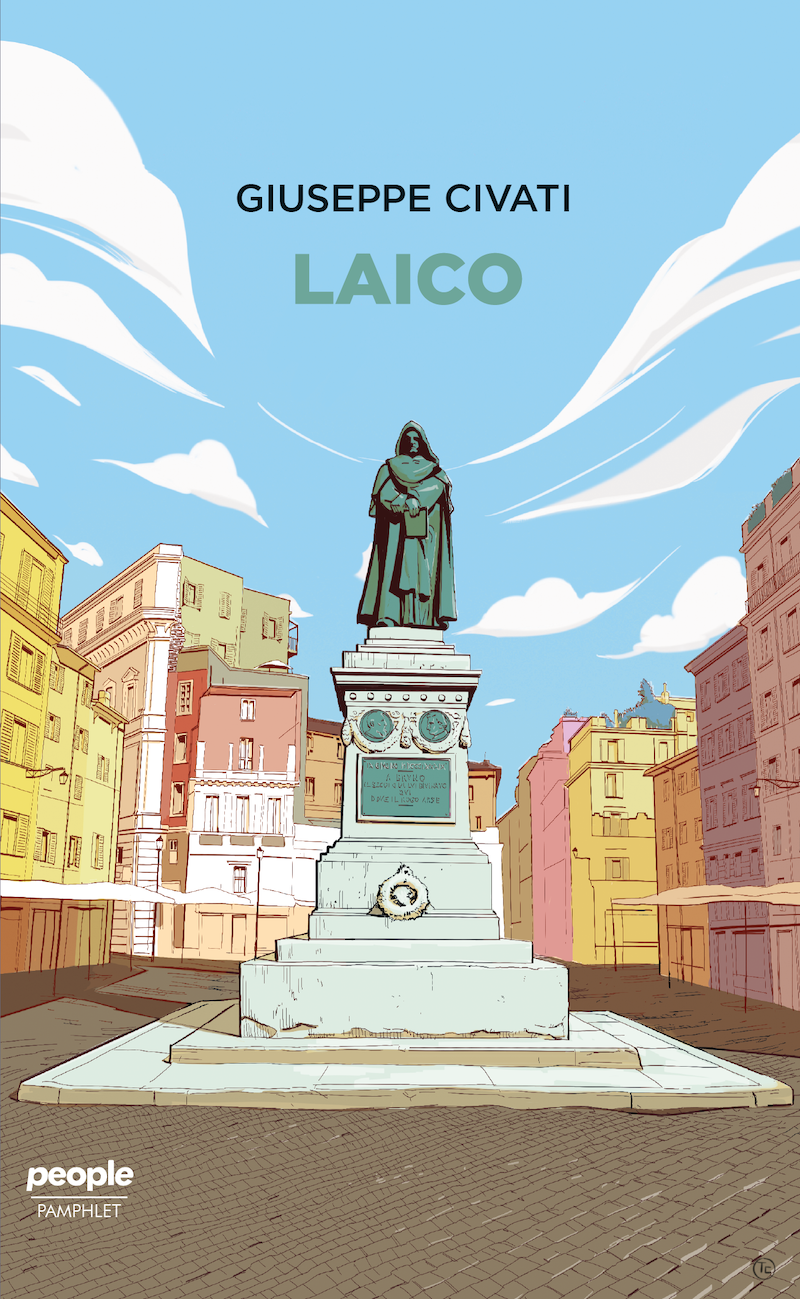










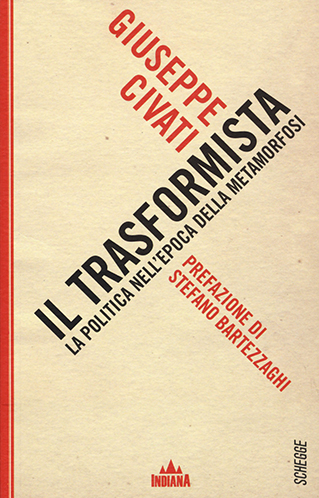


Comments (14)